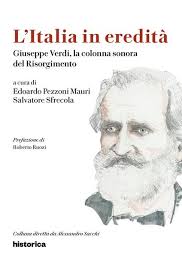di Gianni Torre
Nella collana “l’Italia in eredità”, diretta da Alessandro Sacchi, compare in questi giorni, per essere presentato al Salone Internazionale del libro di Torino, “Giuseppe Verdi, la colonna sonora del Risorgimento” a cura di Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola (Historica, Roma, 2025, pp. 142, € 16,00). Il volume si apre con una Prefazione di Roberto Ruozzi, Presidente della Casa di riposo per musicisti “Fondazione Giuseppe Verdi”, il quale ricorda come il Maestro sia stato non solo uno straordinario musicista “bensì un uomo dal multiforme ingegno, che eccelse in numerosi altri campi della vita economica e sociale. Egli fu in effetti anche un grande imprenditore agricolo, un fine esperto di botanica, un’ineguagliabile benefattore e un amministratore oculato delle sue sostanze costituite essenzialmente da beni agricoli e attività finanziarie, in cui via via investì i cospicui proventi delle sue opere”.
Fu anche un’autorevole esponente della politica impegnato nelle iniziative risorgimentali.
Il tema è ripreso nella Introduzione da Alessandro Sacchi, che ricorda come “il suo contributo al processo di unificazione nazionale già dalla prima rappresentazione del Nabucco, nel 1842, in cui la potenza evocativa del celeberrimo Va pensiero fu subito letta, forse al di là delle intenzioni dello stesso autore, come il lamento di chi subisce l’oppressione e quindi immedesimando gli italiani nel popolo ebraico in cattività, fu enorme”. Per Sacchi Giuseppe Verdi continua ad incarnare al meglio le virtù nazionali, “esempio tuttora vivente di come l’Arte possa esprimere i sentimenti e le aspirazioni condivise da un popolo intero”.
Il primo capitolo è curato da Andrea Borella, Direttore dell’Annuario della nobiltà italiana, ed è dedicato a ricordi vari attinenti alla personalità del Maestro della quale appare emblematico un episodio ai più sconosciuto. Nel 1893 il Ministro della pubblica istruzione, Martini, che si era recato alla prima del Falstaff, aveva rivolto a Verdi calorose parole di elogio. Il giorno successivo, tornato a Roma, ricevette un telegramma inaspettato dal compositore: “leggo Perseveranza annunzio titolo di Marchese. Mi rivolgo a lei come artista perché faccia tutto il possibile onde impedirlo. Ciò non toglie mia riconoscenza, che sarà maggiore se la nomina non avviene. Cordiali ossequi. Verdi”. Il re Umberto I – ricorda Borella – informato dell’accaduto durante un colloquio con Martini, commentò con stupore: “come si può immaginare una cosa simile? Come si può appiccicare al nome di Giuseppe Verdi il titolo di marchese di Busseto? Come si può credere che io sia capace di una tale profanazione? Profanazione mi pare proprio la parola giusta. Il solo fatto di credere a questa sciocchezza è un’offesa per Verdi e per me”.
Ricorda ancora Borella che successivamente Verdi ricevette il titolo nobiliare di Patrizio della Repubblica di San Marino. Titolo ereditario che però non poté passare a nessuno in quanto il Maestro successivamente non ebbe figli naturali.
Molto interessante, ricco di spunti e di curiosità è il capitolo “Verdi e Ferdinando II. Musica e Patria, arte e National Building: la riscoperta del Mare Nostrum”, curato da Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, Professore di Storia del Mediterraneo all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Lo scritto trae spunto dal ritrovamento di un rarissimo spartito verdiano dedicato a Ferdinando II per ricordare i fatti del 1848, la ribellione dei siciliani e la repressione del governo centrale. Ma anche la proclamazione dello statuto, pubblicato l’11 febbraio cui poi seguiranno le costituzioni concesse dal Granduca di Toscana e dal re di Sardegna, Carlo Alberto. L’occasione è quella di ripercorrere quel preciso momento storico in cui l’Italia si apre per la prima volta al liberalismo unitario vagheggiando addirittura una forma di stato federale. Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, storico e scrittore forbito, ricorda la speciale attenzione di Verdi per Napoli e il mare come destino comune d’Italia, le aspirazioni unitarie che vedono Napoli al centro del Risorgimento, “dalla Repubblica Partenopea all’avventura d’Africa, alla riscossa sul Piave del Maresciallo Diaz”. È il primato marittimo e quindi internazionale di Napoli che motiva l’attenzione di Verdi per il San Carlo borbonico, “quella continua presenza che la storia musicale qualifica per Era Verdiana”.
Del “Verdi segreto: un genio tra luci e ombre” si è occupata Dora Liguori, Segretario generale dell’Unione degli Artisti (UNAMS), già docente di canto al Conservatorio “Santa Cecilia”, una lunga presenza sui palcoscenici dei più importanti teatri del mondo, con esperienze d’insegnamento anche in università oltreoceano. Appassionata studiosa di storia, non solo italiana, autrice di libri di successo dedicati al Meridione nella fase complessa dell’unificazione d’Italia ed a romanzi a contenuto storico, da ultimo La Bastardella, che evoca la più grande soprano di tutti i tempi, Lucrezia Agujari, “incantatrice d’Europa e regina del Bel canto italiano”, Dora Liguori naviga con evidente conoscenza approfondita nella vita di Verdi, uomo e musicista, a cominciare dall’iniziale studio presso il Conservatorio di Milano. Ricorda che Verdi, “come tutti i giovani del Nord, in particolar modo a Milano, mal sopportando l’imperante dominio austriaco, erano in grande fermento” ed alimentavano le società segrete, come la Massoneria, l’“Arte Reale”, ricorda Dora Liguori, alla quale Verdi aderì entrando a far parte della Loggia bolognese.
Vivace l’esposizione del Verdi alle prime armi e nel periodo peggiore, per la morte dei figli e della moglie, quando il Maestro sembrava voler abbandonare la composizione finché incontrò un libretto (a rotolo) di Temistocle Solera, Nabucodonosor. “Fu allora che – ricorda la Liguori – come lo stesso Verdi ci racconta, il “fato” in versione questa volta compassionevole gli volle tendere la sua trappola. In breve, il musicista rientrato in casa gettò via il libretto che non desiderava neppure leggere ma fortuna volle che, nel cadere, il rotolo si aprì e che i suoi occhi si posarono sui versi “Va pensiero, sull’ali dorate” di un popolo oppresso che piange come lui! E così, come per destino… les jeux sont faits”.
Il dice delle opere più importanti del Maestro di Busseto, lungo la vita, i successi, le critiche che sulle prime spesso non mancarono, come sempre accade per opere innovative che ancora il pubblico non è in condizione di apprezzare pienamente.
C’è, poi, la vicenda personale e professionale dell’incontro con Giuseppina Strepponi per la quale il Maestro scrive un’opera fondamentale, La Traviata, una delle più rappresentate con arie molto popolari, ricorrenti nelle trasmissioni radiofoniche e televisive con argomenti musicali.
Un capitolo tutto da leggere, ricchissimo di informazioni che sfiorano anche l’impegno politico di Verdi a seguito della nomina a Senatore del Regno, dopo essere stato eletto deputato su sollecitazione di Cavour.
Non mancano riferimenti ad altri episodi della vita privata come quello, poco noto ai più, del figlio della nipote Maria Filomena, Angiolo, il quale “imbracciato un fucile, sparò ad una giovane cameriera di Casa Verdi. Al momento del delitto nessuno era in casa – spiega la Liguori -. Dal referto medico la giovane donna risultò incinta. Sarà stato forse questo il motivo dello sparo? Oppure una reazione violenta di Angiolo a un tentativo di ricatto da parte della donna? Chissà!” E l’autrice ci lascia nel dubbio.
Capitolo di straordinario interesse che evidenzia la cultura della Professoressa Liguori e la sua grande capacità di trasmettere sensazioni e valutazioni su uomini e situazioni.
“Giuseppe Verdi, il padre della musica italiana” è il capitolo scritto da Silvio Mastrocola, Professore di letteratura europea all’Università degli studi Suor Orsola Benincasa, il quale affronta il tema dell’importanza della musica in qualche modo richiamando il titolo del libro, “la colonna sonora del Risorgimento”. Ricostruisce lo spirito del tempo, il panorama culturale nel quale si colloca il melodramma “che aggiungeva la musica all’incanto delle scenografie con la superba azione del canto e la nuova straordinaria importanza della recitazione che, naturalmente, si rifaceva ai grandi modelli drammatici”. Interessante molto l’esposizione della concezione sociale che è alla base anche della scelta delle opere musicate da Verdi e il riferimento ad alcune specifiche nelle quali il Maestro “ha espresso il punto più alto del genere italiano nella musica e, soprattutto, ha saputo trovare le note più alte dell’umanità e dell’arte”.
“Verdi e non solo: il contributo della lirica alla formazione di una coscienza unitaria”, è il capitolo che si deve alla penna di Adriano Monti Buzzetti Colella, giornalista Rai, noto al pubblico per essere autore di importanti servizi culturali per il TG2. Scrittore facondo, Adriano Monti Buzzetti Colella ci trasmette considerazioni importanti su aspetti di costume riferiti ad alcune opere fra le più note dalla Aida alla Giovanna d’arco alla Battaglia di Legnano, sottolineando come il Maestro alterni temi storici e suggerimenti patriottici, tra l’imperversare dei controlli e obiezioni ufficiali che in qualche modo venivano tollerate dall’autorità, considerata dalla sua notorietà e la sua popolarità. E conclude. “Il risultato? La colonna sonora del nostro Risorgimento, un successo trionfale da 150 anni”. Una verità che tutti percepiscono.
De “L’impegno politico e sociale del Maestro Verdi nella società e in Parlamento” ha scritto il nostro Direttore, Salvatore Sfrecola, che ha voluto ripercorrere l’impegno del Maestro, patriota a tutto tondo, fin da quando viveva a Parigi tra il 1847 e il 1848, anni cruciali della storia europea e del Risorgimento italiano, nei quali Verdi stimola amici e autorità a prendere posizione per avviare l’unità della Nazione. Il capitolo percorre i prodromi del movimento risorgimentale, i moti in Italia meridionale e in Piemonte suscitati dall’entusiasmo per l’elezione del Papa Pio IX, presentatosi come liberale, e per la salita al trono del principe Carlo Alberto di Savoia Carignano, il Re che, come ha scritto Silvio Bertoldi, ha tentato di “fare l’Italia”.
Il capitolo segue, attraverso scritti tratti dall’epistolario di Verdi, le iniziative, le opinioni, le sollecitazioni, i sentimenti del Maestro in parallelo con le pagine più note del Risorgimento, dalle “5 giornate di Milano” ai combattimenti della prima guerra d’indipendenza contro l’Austria, una scelta che, sottolinea l’Autore, dimostra il coraggio e una certa dose d’incoscienza del re Carlo Alberto che sfida l’Austria, considerato che il piccolo Piemonte, con un piccolo esercito, andava a impegnarsi in una guerra contro la più grande armata dell’epoca, guidata dal maresciallo Radetsky, un mito nella cultura militare austriaca, vincitore di Napoleone a Lipsia.
Dice l’autore anche delle attività politiche a margine di Giuseppe Verdi che viene eletto deputato su sollecitazione personale di Cavour, al quale il Maestro non potette dire di no, anche se avrebbe voluto continuare a fare il patriota fuori dal Parlamento. Divenne successivamente senatore del Regno, come ha ricordato anche la professoressa Liguori. Quindi l’attività politica di Verdi rimane limitata a queste presenze poco significative. Però il Maestro era talmente popolare che qualunque cosa facesse o proponesse veniva seguito.
Nella fase finale della sua vita politica Verdi s’impegna moltissimo per lo sviluppo delle infrastrutture civili in tutto il territorio del suo collegio, in particolare attraverso la Fondazione dell’ospedale di Villanova sull’Arda di cui sorveglia sempre con grande attenzione l’amministrazione. In vecchiaia, dopo la morte di Giuseppina Strepponi, nel 1897, “in un orizzonte di attività pubblica più limitato, Verdi s’impegna nella sua più nota opera filantropica, la Casa di riposo per i Musicisti di Milano, che vede la luce nel 1899, e nella quale viene sepolto alla sua morte, avvenuta il 27 gennaio 1901”.
Un’opera importante questa dedicata al grande musicista nella collana “L’Italia in eredità”, diretta da Alessandro Sacchi, che si aggiunge ai precedenti volumi su Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso di Cavour, Umberto II e Umberto I.
Buona lettura.