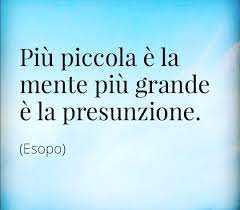di Salvatore Sfrecola
Anche i politici, come tutti, possono sbagliare. Ma a differenza delle persone comuni non si deve sapere perché ammettere un errore significa agli occhi dei cittadini-elettori perdere di prestigio. In Italia, ovviamente, perché ovunque, o quasi ovunque, l’elettore apprezza l’onestà intellettuale di chi riconosce di aver sbagliato e si corregge, magari ringraziando a denti stretti chi ha suggerito la strada giusta. Dovrebbe essere sempre così perché perseverare nell’errore “è diabolico”, come sappiamo da un antico adagio, e può aggravare le conseguenze di un errore. E così, spesso, per non ammettere di aver sbagliato, si cerca di rimediare accusando chi lo ha segnalato dicendo che è pregiudizialmente un nemico, con l’effetto che, come si dice “la toppa è peggio del buco”, ovunque con varie espressioni dialettali questa antica regola viene richiamata.
Né sarebbe corretto attribuire l’errore ad un collaboratore, al classico consigliere o consulente, al dirigente del settore competente o al Capo di gabinetto che tutte le posizioni di “diretta collaborazione” riassume e fa proprie. E qui va affrontato un altro aspetto dell’eventuale errore. Spesso è la fretta di decidere perché “è scritto nel programma di governo” o perché “ce lo chiedono i cittadini che ci hanno votato”. Naturalmente nell’uno e nell’altro caso il più delle volte il programma era generico e non definiva il dettaglio che, trascurando le possibili alternative, sulla base di una insufficiente istruttoria è divenuto un provvedimento legislativo o amministrativo. E qui va detto che sarebbe sbagliato attribuire l’errore al collaboratore del politico, alla sua professionalità. Perché a guidare la scelta sbagliata è spesso il rapporto che si è instaurato tra il consigliere e l’autorità politica. Che sovente non ammette ritardi e non vuole essere contraddetta, non tollera consigli su come realizzare l’iniziativa né su una possibile alternativa. È così e così va fatto perché quella iniziativa è anche un manifesto politico. Così, per fare un esempio, Matteo Salvini che da Ministro dell’interno è stato accusato di “sequestro di persona” per aver tenuto per giorni su una nave dei profughi salvati in mare, sostiene di essere stato inquisito perché difendeva i confini d’Italia. L’ha buttata in politica, come è consueto, accusando i giudici di una scelta “politica”, nientemeno che contraria alla difesa dei confini della Patria. Può darsi che qualche magistrato abbia avuto una visione dell’evento condizionata da sue personali idee, che abbia forzato l’interpretazione dei fatti, come dimostra il fatto che il Tribunale abbia poi assolto il Ministro. Ma nessuno al Governo si è posto il problema se la gestione dei naufraghi mantenuti a bordo della nave militare italiana poteva essere gestita diversamente, ad esempio trattenendo le persone a bordo per motivi sanitari o per qualche altra ragione meno controversa come appariva fin dall’inizio dalle cronache dei giornali e dalle dichiarazioni dei politici dell’opposizione.
Un tempo le istituzioni avevano rispetto per le decisioni dei giudici, anche quando sgradite. Il caso dell’on. Andreotti che saluta il Procuratore della Repubblica Caselli e gli stringe la mano dopo aver ascoltato una dura requisitoria sulle sue presunte responsabilità non è solamente un fatto di buona educazione. È un gesto di civiltà.
Accade così che il politico dispone: si fa “punto e basta” perché così fa comodo all’immagine di chi decide e non tollera che possa essere suggerita una scelta diversa, magari più normale anche se meno appariscente. E il consigliere, che nella maggior parte dei casi è persona dotata di elevata professionalità e di sicura esperienza, non è in condizione di dire al politico che non si può fare o non si può fare così. Perché nella maggioranza dei casi il rapporto con il politico è di subordinazione psicologica, si teme di perdere la fiducia dell’autorità perché notoriamente in politica si ricerca il fedele più che il leale. E allora accade che ciò che si poteva fare in altro modo, più conforme alle leggi ed alla loro interpretazione, si realizza forzando le norme con conseguenza di incappare in una censura dell’organo di controllo o di qualche giudice chiamato in causa da chi vi ha interesse, un altro politico, un sindacato, un’associazione. A questo punto l’unica strada che i politici ritengono comunque giovi loro è dare la colpa alla Corte dei conti o ai giudici, definiti toghe rosse o grigie a seconda della prospettiva in cui si pone chi governa.
È un po’ quello che si legge sui giornali che appoggiano senza nessun dubbio con titoloni la maggioranza di governo e dalle dichiarazioni dei politici a proposito del protocollo Italia-Albania e sulla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, a proposito della definizione di “paese sicuro” che, come dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista televisiva è deciso dal Governo sulla base di istruttorie complesse cui provvede il Ministero attraverso le sue diramazioni in tutti i paesi del mondo che consentono di conoscere la situazione della tutela dei diritti nei vari paesi. Per cui, ad esempio, è certamente sicuro, si sente dire, l’Egitto, meta di migliaia di cittadini italiani in vacanza, mentre i giudici ritengono che la decisione sulla sicurezza debba essere valutata caso per caso con riferimento alla persona, implicito nel fatto che l’Italia è intervenuta sul caso di Giulio Regeni e in favore del giovane studente di Bologna Patrick Zaki imprigionato in Egitto per 22 mesi, perché accusato di diffondere notizie false tali da minacciare la sicurezza nazionale. Il concetto di sicurezza non attiene all’intero territorio ma potrebbe riguardare parti del territorio e singole persone che per la loro posizione per le loro iniziative per cui potrebbero non essere al sicuro nel loro paese. In sostanza la Corte dell’Unione europea ha deciso che uno Stato membro non può includere nell’elenco dei paesi sicuri quelli che non garantiscono una protezione sufficiente a tutta la loro popolazione (eventuali eccezioni per categorie potranno operare solo dall’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario, cioè dal 2026). Il fatto che uno Stato membro designa con atto legislativo i paesi sicuri non esclude il controllo del giudice, così da assicurare piena ed effettiva tutela al richiedente protezione. Il giudice può pervenire a conclusioni diverse da quella presupposta dalla designazione di paese sicuro purché utilizzi elementi informativi messi a disposizione dalle parti in giudizio così da assicurare la pienezza del contraddittorio. Dire come si è sentito che “la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche” è una conclusione palesemente contraddetta da una lettura della sentenza. Una prima considerazione – scrive su “Il Fatto Quotidiano” Filoreto D’Agostino, giurista insigne, già Presidente di sezione del Consiglio di Stato – il governo Meloni attinge a consulente giuridiche piuttosto modeste se si aspettava una pronuncia diversa da parte della Corte UE. Per comprendere l’estrema debolezza e pretestuosità delle tesi governative basta ricordare il fondamento giuridico delle vicende oggetto di tutela giurisdizionale: la sopravvivenza e la dignità di chi reclama lo status di rifugiato, cioè il diritto alla vita, che è presidiato dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 3) e dalla Carta dei diritti fondamentali Ue (art. 2). Come è immaginabile che una situazione potenzialmente di obiettivo e gravissimo pericolo per un essere umano non debba ricevere la più ampia ed effettiva tutela?” si è chiesto D’Agostino. “La conclusione della Corte Ue era totalmente prevedibile e coerente alla migliore tradizione giudiziaria perché preordinata alla tutela della vita”.
Credo che questo incidente sarebbe stato evitato se al momento di decidere il Governo avesse consultato chi di dovere, non persone in condizione di subordinazione, i soliti “consiglieri del principe” ma persone libere, giuristi, magistrati, magari in pensione quindi non implicati nelle decisioni che i giudici avrebbero dovuto adottare, e probabilmente sarebbe stata individuata una soluzione diversa da quella scelta. E si sarebbe evitato quella bagarre sui giornali di area e sui social dove ovunque, i fedelissimi del governo sparano a zero sulle “toghe rosse” e sui giudici che vorrebbero “fare i politici” e decidere “sulla gestione dei confini della patria”. La politica che ritiene di trarre giovamento da queste polemiche a mio giudizio sbaglia. Come sbaglia a scegliere i fedeli anziché i leali, quelli che dicono come la pensano in tutta onestà. Gli affidabili più che i fedelissimi.