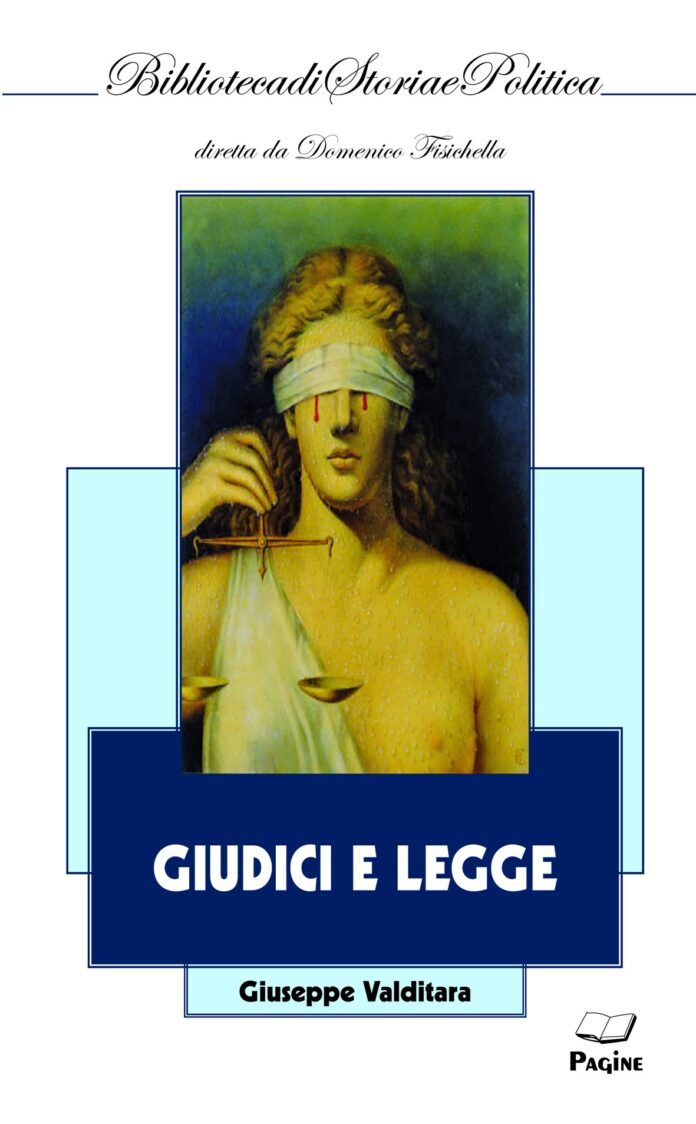di Salvatore Sfrecola
Ho ricordato più volte, anche di recente, un episodio dall’indubbio tratto istituzionale. Al termine della requisitoria del Pubblico Ministero, Giancarlo Caselli, nel processo che lo vedeva imputato di gravi reati a Palermo, l’onorevole Giulio Andreotti aveva raggiunto lo scranno del magistrato per stringergli la mano. Non era, quello dell’esponente democristiano, un gesto teatrale in funzione delle cronache. Avendolo conosciuto so per certo che quel politico di lungo corso, che aveva iniziato giovanissimo da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con Alcide De Gasperi, aveva sentito il dovere di salutare il suo accusatore in virtù di un atteggiamento di rispetto istituzionale ritenuto normale nei confronti di chi amministra la Giustizia, al di là del contrasto delle posizioni e delle opinioni.
Non era stato il primo atteggiamento di sereno distacco dinanzi ad iniziative della magistratura che pure avevano scosso la classe politica. Nel 1992, a Milano, dinanzi a Francesco Saverio Borrelli, a Gerardo D’Ambrosio, a Gherardo Colombo, ad Antonio Di Pietro, a Piercamillo Davigo e a Francesco Greco, l’atteggiamento dei politici chiamati a chiarire come fossero state finanziate le iniziative dei loro partiti, da Arnaldo Forlani a Bettino Craxi, era stato sempre molto rispettoso. Mai emersa nelle parole pronunciate, nel corso degli interrogatori e nei servizi giornalistici che ne riferivano, una qualche forma di accusa ai magistrati che ne indicasse opinioni preconcette, come se fossero pregiudizialmente ostili alle persone e alle forze politiche di provenienza. Si disse, è vero, che il pool di “mani pulite”, così furono chiamati i sostituti che istruirono i processi per corruzione, non aveva “disturbato” il Partito Comunista Italiano (P.C.I.) se non nella persona di Primo Greganti che, sottoposto a misura restrittiva della libertà, non aveva rivelato fatti e comportamenti penalmente rilevanti come era accaduto ad altri, divenuti immediatamente loquaci alla prima convocazione.
Sta di fatto che in quel clima surriscaldato che ha segnato, come è passato dalla cronaca alla storia, la fine della Prima Repubblica, il rispetto delle istituzioni non è mai venuto meno. Anche allora c’erano state leggi “ad personam” che avevano inciso sulla prescrizione di alcuni processi, ma non si era mai giunti al configurare, come scrivono oggi i giornali, un contrasto tra politica e magistratura, accusata, sia pure “per una parte”, di lavorare a favore delle forze di opposizione. Anzi, di muoversi quasi fosse un partito politico, come a taluni della maggioranza appare evidente.
Capiamoci bene. Non c’è dubbio che vi siano alcuni magistrati, i quali evidentemente hanno sbagliato “mestiere”, che decidono sulla base di pregiudizi ideologici, come ha dimostrato il professor Giuseppe Valditara, attuale Ministro dell’Istruzione, in un libro “Giudici e Legge”, edito da “Pagine” nel 2015 nella “Biblioteca di Storia Politica” diretta da Domenico Fisichella, dove ha messo in risalto le distorsioni interpretative delle leggi che hanno caratterizzato alcuni settori della magistratura ordinaria. Non singoli errori ma indirizzi emersi nel corso di Convegni e Congressi. Settori minoritari che in Italia possono essere ricondotti alla ragione attraverso il sistema, con gli appelli cui il Governo può ricorrere officiando l’Avvocatura Generale dello Stato. È normale che possa accadere, ma va evitato uno scontro istituzionale. Ritenere che il governo non sbagli mai o che i giudici interpretino la legge per fare politica, per cambiare la maggioranza è ugualmente sbagliato. E se è la politica a sfruttare il contrasto perché può far comodo sul piano elettorale per mantenere consensi, è una scelta che si paga, perché quando una istituzione viene delegittimata è lo Stato che perde credibilità.
Per completezza dobbiamo, invece, constatare che parte della classe politica è scarsamente dotata di adeguata preparazione giuridica e che si avvale di yesmen che non hanno l’autonomia psicologica per dire alla politica che non si può fare come richiesto e che magari lo stesso obiettivo può essere raggiunto in altro modo. Anche dire che la magistratura deve perseguire l’interesse nazionale e non lo fa se non condivide le scelte del Governo è una colossale sciocchezza. I Giudici applicano la legge che il Parlamento ha votato e se c’è contrasto sulla sua applicazione, se la legge non può raggiungere l’obiettivo immaginato, perché un giudice dubita della sua costituzionalità o del rispetto della normativa europea, decide la Consulta o la Corte dei Giustizia Ue. Inoltre, se effettivamente, alla prova della sua applicazione, la legge risulta inadeguata, il Parlamento può, anzi deve, correggerla emendandola per renderla più idonea a perseguire l’obiettivo prefissato.
È normale che avvenga. Questo è lo Stato di diritto.