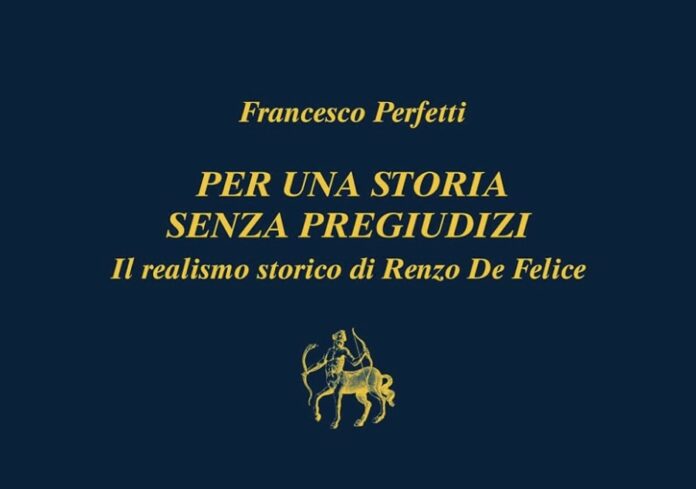di Salvatore Sfrecola
Questo volume di Francesco Perfetti, dal titolo particolarmente stimolante, “Per una storia senza pregiudizi – il realismo storico di Renzo De Felice” (Aragno Editore, Torino, 2025, pp. 461, € 30,00), è un omaggio ad uno straordinario Maestro della storiografia italiana con il quale l’A. ed altri importanti studiosi di storia contemporanea si sono formati ed hanno collaborato negli ultimi decenni. È una biografia “intellettuale e politica”, come si legge nel risvolto della prima di copertina, di uno storico dagli interessi molteplici, che ha lasciato l’impronta del suo pensiero nella ricerca sui fatti e le personalità che hanno segnato gli anni convulsi della storia italiana ed europea che dalla Rivoluzione Francese e dall’epopea napoleonica giungono alla crisi della democrazia ed alla nascita del fascismo. Un’esperienza di ricerca e di riflessioni che Renzo De Felice ha consegnato nella monumentale biografia di Mussolini, spesso al centro di polemiche di taglio politico che giustificano il richiamo a quella storia “senza pregiudizi” che Francesco Perfetti indica come la regola della ricerca per ogni autentico studioso di storia. Potremmo dire da Erodoto in poi. Che potremmo integrare con il pensiero di Federico Chabod sulla conoscenza storica che – sottolinea – “é conoscenza del “vero”: dell’unico vero pensabile che non si può ottenere se non attraverso le forme concrete ed individuali della storia, per quella filosofia che, prendendo le mosse dal Vico, s’è poi incarnata nell’idealismo moderno, comunque almeno di “una” forma di verità anche per altre tendenze, non idealistiche, del pensiero moderno”(Lezioni di metodo storico”, Editori Laterza, Bari, 2006, 9).
Il volume è dedicato a Nadia, recentemente scomparsa, che di Francesco è stata, come scrive, “compagna insostituibile e supporto fondamentale degli anni più felici della mia vita, ricordando con un tenero sentimento di nostalgia i momenti più belli di un reciproco, profondo, sincero amore e le emozioni più profonde di due anime unite in un rapporto simbiotico”. Chi ha conosciuto Nadia Perfetti ed è amico di Francesco affettuosamente condivide il ricordo per questa donna garbata e gentile che gli è stata accanto non di rado stimolandolo a ricercare ed a scrivere.
La Prefazione è un ricordo dell’incontro con De Felice. L’aveva patrocinato Augusto Del Noce, con il quale il giovane Perfetti collaborava, occupandosi di storia del pensiero politico, avendo maturato dal punto di vista intellettuale un profondo legame col grande filosofo cattolico. Che per il giovane assistente universitario rappresentava un preciso punto di riferimento, basato su un rapporto umano e intellettuale alimentato da una consuetudine di lunghi colloqui, a casa del maestro o in lunghe passeggiate. Un “metodo” che evoca la scuola di Aristotele dove l’approfondimento degli studi si svolgeva anche passeggiando, come ci è stato tramandato.
Del Noce, scrive Perfetti, “con quella sua aria apparentemente svagata e fuori del tempo, si intratteneva a lungo discorrendo di filosofia o di politica”. Era stato chiamato a Roma a ricoprire la cattedra di Storia delle dottrine politiche, lasciata libera da un grandissimo studioso come Rodolfo de Mattei al quale pure Perfetti era legato, anche per amicizia culturale ed ideale con il figlio, Roberto, storico anch’egli, del Cristianesimo, che il giovane de Mattei cominciava a studiare e insegnare.
Insediatosi a “La Sapienza”, nella Facoltà di Scienze Politiche, ricorda Perfetti che “Del Noce pensò di festeggiare l’avvenimento con un incontro conviviale. Vi presero parte oltre al suo predecessore, ai collaboratori di quest’ultimo che sarebbero naturalmente divenuti suoi assistenti e pochissimi altri invitati. C’era anche Renzo De Felice e molti dei presenti probabilmente si saranno interrogati su questo invito a uno studioso appartenente a tutt’altra disciplina e con il quale, forse, pochi potevano pensare che filosofo cattolico avesse un profondo rapporto di conoscenza se non di amicizia”. Rapporto che, in realtà, c’era almeno da un punto di vista intellettuale, da tempo, e sarebbe durato a lungo, tanto è vero che la pubblicazione del volume postumo di Augusto Del Noce su Giovanni Gentile, per un’interpretazione filosofica della storia contemporanea, venne caldeggiata fortemente dallo storico.
Quella cena favorì un lungo colloquio con De Felice nel corso della quale Perfetti ricorda di aver fatto presente quali fossero i suoi interessi, per la storia della nazionalismo italiano, del nazionalismo francese e del sindacalismo rivoluzionario. Fu l’inizio di un “sodalizio” professionale che si sarebbe consolidato in incontri quasi settimanali e telefonate, in “un rapporto di confidenza e di partecipazione intellettuale tanto profonda”, nonostante Perfetti non appartenesse alla sua scuola storiografica nel senso stretto. In quanto allievo di Franco Valsecchi, “grande storico del 700 e dell’età risorgimentale proveniente, ricorda Perfetti, dal filone storiografico che aveva in Gioacchino Volpe e in Benedetto Croce i suoi punti di riferimento, un vecchio liberale di destra che occhieggiava con malcelata e nostalgica simpatia allo scomparso mondo asburgico. E, com’è comprensibile, molte idiosincrasie di Valsecchi – la sua antipatia per l’illuminismo e la Rivoluzione Francese – così come molte delle sue passioni o simpatie – l’Austria imperiale di Maria Teresa e di Francesco Giuseppe e la Francia di Napoleone III – erano state da me, quasi istintivamente recepite se non addirittura assimilate”. Idee lontane dalla cultura di De Felice, proveniente dall’area culturale della sinistra comunista. Eppure Perfetti dà conto di un rapporto umano e di una “profonda confidenza”, divenuta presto anche un rapporto di collaborazione scientifica e fonte di stimoli di riflessione, “non soltanto sulla ricerca storica e sullo stato della storiografia ma anche sull’attualità politica”.
La stima del Maestro per l’allievo, pur accademicamente inquadrato in una disciplina diversa dalla sua, trova presto conferma nella proposta della Presidenza del Vittoriale degli italiani e nella sollecitazione a partecipare al concorso ad ordinario. E ricorda, con commozione, la telefonata iniziata con quel “buongiorno Collega”, che gli comunicava il successo nel concorso. Cui seguì un brindisi “con un alcoolico di quelli che gli erano stati proibiti dal medico, segno di generosità e della umanità di De Felice, del calore con il quale egli accompagnava le proprie amicizie”. Nonostante apparisse burbero e solitario, De Felice era, “al contrario, uomo gentilissimo, cordiale, disponibile, dotato di sottile senso dell’umorismo e di gusto per una pungente ironia”, come può confermare chi lo ha conosciuto e frequentato. Per una telefonata o per un incontro, magari per un consiglio o un aiuto era sempre disponibile. Molti di coloro che si sono formati alla sua scuola sono stati non solo aiutati ma indirizzati nell’individuazione di un oggetto di studio, proprio da lui che, non di rado, con grande magnanimità forniva loro non solo le prime indicazioni archivistiche ma anche i documenti spesso inediti che aveva rintracciato o che gli erano stati donati.
Diffidava dei giornalisti, De Felice, in particolare della loro continua ricerca di sensazionalismo, delle loro domande o troppo ingenue o troppo furbe, della loro tendenza alla superficialità. Cercava di tenerli alla larga. Si fidava di pochissimi. Perfetti ricorda Stefano Folli, Pasquale Chessa e Paolo Mieli, che era stato suo allievo, collaboratore all’università e da lui aveva appreso non solo come studiare davvero la storia ma anche il modo di affrontarne i problemi. E richiama una pagina di Mieli che illustra bene quello che definisce il significato per i suoi allievi: “ci fece capire come si individuano i risvolti minori delle grandi vicende, come si scoprono i significati nascosti tra le pieghe degli eventi, quanto è importante provare (quantomeno provare) a capovolgere il punto di vista tradizionale su momenti chiave del passato, come si possono cogliere i legami meno espliciti che mettono in connessione questo passato con il presente. Ci insegnò a leggere bene i libri, a scovare quel breve periodo, quella nota significativa nascosta tra decine di pagine apparentemente banali, a leggere tra le righe e, per procedere a tale lettura, a smontare i meccanismi della dissimulazione. Ci fece assaporare il gusto del dubbio, della contraddizione in sé, della sfida che si produce nel momento in cui si è costretti a prendere coscienza del fatto che i conti non tornano”. Una lezione di metodo storico che sarebbe bene fosse presente a tutti coloro che di storie scrivono.
Continuando a delineare del carattere del Maestro, Perfetti ricorda che non amasse la vita di società, non fosse un frequentatore di congressi scientifici limitandosi ad incontri di studio che riteneva davvero importanti. Aveva una capacità di lavoro davvero prodigiosa. Curava personalmente le ricerche per i libri che andava scrivendo. Insomma non si serviva dell’aiuto di collaboratori, come qualcuno ha insinuato. “Troppo forti erano in lui il piacere della ricerca e il “gusto” della scoperta e troppo personale e inimitabile il suo stile, all’apparenza pesante e poco lineare… che costringeva, sì, il lettore ad uno sforzo di concentrazione ma che, al tempo stesso, rivelava una perfetta padronanza della lingua”. Perfetti ricorda di aver sostenuto che la scrittura di De Felice “era tutt’altro che sciatta: difficile, forse sì, e impegnativa per il lettore comune, ma corposa, niente affatto scorretta ed anche, vorrei aggiungere stimolante”.
Aveva una raffinata sensibilità per la storia culturale. La sua cultura storica era molto vasta. Aveva letto i grandi storici della storiografia, Jean Jaurès, Albert Mathiez, George Lefebvre, Jacques Godechot. Perfetti sottolinea come uno dei libri di maggior successo di De Felice tradotto in tante lingue, “quello dedicato alle interpretazioni del fascismo è, in fondo, un lavoro classico di storia della storiografia”. De Felice aveva un altro grande interesse, retaggio delle lezioni di Federico Chabod, quello del “metodo storico” che poi a ben vedere “sfiorava anche il tema in certa misura filosofico del significato della natura della storia. Era convinto della necessità che ogni ricerca presupponesse l’individuazione di un “problema storico” da affrontare con gli strumenti propri di un approccio che univa i canoni metodologici della storiografia filologico-erudita con quelli propri della storiografia etico politica o, se si preferisce, e più in generale, dello storicismo idealistico dal quale, in fondo, egli proveniva”.
L’eredità di De Felice, sottolinea Perfetti, “è certamente storiografica, soprattutto in campo metodologico – con il richiamo all’esigenza di scrivere la storia raccontando i fatti come si sono verificati e posponendo il momento della interpretazione a quello della ricostruzione degli avvenimenti – ma è anche forse soprattutto morale e civile. Il richiamo a “La strana disfatta” di Block, testimonianza personale e intellettuale di un grande storico di fronte alle tragedie del suo tempo, è la conferma, a mio modesto parere, della compresenza in De Felice delle esigenze di una ricerca neutrale e oggettiva dei fatti storici con il proposito di lasciare anche un messaggio con una valenza etica”. È un po’ la traccia del migliore giornalismo, quello che impone che i fatti narrati siano distinti dalle opinioni, anche per favorire il dibattito e ulteriori approfondimenti.
Troppo assorbito dalla ricerca e dalla scrittura, a De Felice non interessava la politica attiva tanto che, quando gli venne offerta una candidatura nelle liste del Partito Liberale Italiano non l’accetto, ma volle scrivere una lettera, destinata ad essere diffusa alla vigilia delle elezioni, con la quale ringraziava per l’offerta, spiegava i motivi del rifiuto e dichiarava di condividere appieno la politica liberale. Qualche anno più tardi, nel maggio del 1979, in occasione delle nuove elezioni rilasciò un’intervista spiegando le ragioni della sua simpatia nei confronti del Partito Liberale cui a suo giudizio sarebbe dovuto andare un premio alla coerenza.
“Il suo itinerario storiografico – scrive Perfetti a conclusione della Prefazione – De Felice lo ha percorso con l’obiettivo di “emancipare la storia dall’ideologia, di scindere le ragioni della verità storica dalle esigenze della ragion politica”. E sottolinea come, “pur non essendo riconducibile a una precisa scuola, De Felice fa parte di una linea storiografica nella quale convivono, accanto al rigore metodologico, una forte pulsione etico politica e la convinzione del primato della storia politica. La sua ricerca si inserisce così all’interno della tradizione idealistica e storicistica italiana lungo il tracciato che da Benedetto Croce giunge a Delio Cantimori passando per Giovanni Gentile, ma, al tempo stesso, si sviluppa come costola del realismo storiografico di Gioacchino Volpe e si muove all’insegna del recupero del modo oggettivo di fare storia tipico di un Leopold von Ranke. Sotto questo profilo De Felice appartiene a un filone nel quale si ritrovano, pur con le loro specificità, studiosi come Federico Chabod, Rosario Romeo, Giovanni Spadolini”.
Insomma, “una storia senza pregiudizi”.
Delineata nella Prefazione la personalità umana e scientifica di De Felice il volume affronta il ruolo che studioso ha avuto nell’approfondimento delle vicende delle quali si è occupato nel corso degli anni, a cominciare dallo studio dell’età dell’Italia giacobina, un interesse che a De Felice derivò dall’attenzione per il pensiero illuministico europeo e dalla lunga frequentazione e dalla profonda amicizia con Delio Cantimori, ma anche dal sodalizio con Giuseppe De Luca. In questo contesto – ricorda Perfetti – nacquero i primi saggi sugli ebrei nella Repubblica romana del 1798-99 e sulla vita teatrale nella stessa Repubblica romana. Ugualmente l’attenzione per figure significative dell’evangelismo rivoluzionario come l’Abate Della Valle e alcuni aspetti socio economici della realtà romana e laziale nel periodo rivoluzionario, nonché il volume sugli illuminati e sul misticismo rivoluzionario che, attraverso lo studio delle figure di Ottavio Cappelli e di Suzette Labrousse, “indagava il peso del fatto mistico e della mentalità mistica nel Settecento cogliendone – scrive Perfetti – il nesso con il misticismo apocalittico e l’escatologismo rivoluzionario utilizzando un approccio che risentiva pure dell’influenza di Emilio Servadio e di Miguel Battlori”. E sottolinea come De Felice abbia dato al dibattito sul giacobinismo un contributo notevolissimo attraverso saggi e volumi che indicano agli studiosi nuovi percorsi da seguire. Opere nelle quali il giovane De Felice era ancora partecipe dell’indirizzo storiografico marxista e “la stessa scelta tematica dei suoi primi interessi, il triennio rivoluzionario, non appare casuale anzi è certo congruente con una certa tendenza della storiografia italiana del dopoguerra a leggere la vicenda del giacobinismo in una chiave, per dire così, attuale che metteva in relazione tra loro i temi del rapporto fra azione e politica nei centri urbani e azioni politiche nelle campagne, tra ideologia azione e politica, nonché tra questa e i problemi di classe di equilibrio sociale”.
L’Italia giacobina – annota Perfetti – rappresenta un momento importante per il dibattito storiografico sul tema e per De Felice costituisce la conclusione delle incursioni nel terreno dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica prima di volgersi alla ricostruzione storica del periodo fascista.
Il terzo capitolo del volume è dedicato a De felice storico dell’ebraismo, prima e durante il fascismo. In realtà De Felice aveva avuto un grande interesse per l’ebraismo fin dagli esordi della propria attività di studioso. Il suo primo saggio lo aveva scritto non era ancora laureato. Lo aveva dedicato alla situazione degli ebrei romani e al loro atteggiamento nei confronti, prima dello Stato pontificio, nell’ultimo quarto del secolo XVIII, e poi verso la Repubblica romana del 1798-99, un lavoro che sottolinea il fatto che gli ebrei avevano partecipato attivamente al movimento di formazione di una coscienza nazionale italiana ed erano stati protagonisti di un processo di assimilazione particolarmente rapido e completo proprio per il carattere specifico che assume la coscienza nazionale italiana, dal superamento del particolarismo municipale e del cosmopolitismo cattolico e quindi a carattere nettamente laico.
L’arrivo dell’esercito francese per la popolazione ebraica costituisce un momento essenziale e che la libera da un avvilente stato di inferiorità e di emarginazione. De Felice nel 1955 con un ampio saggio apparso sulla rivista “Movimento Operaio” offre un vivace affresco storico sulla situazione dell’ebraismo nei paesi dell’Europa centro occidentale che mostrava come il processo di emancipazione degli ebrei, logica conseguenza della rivoluzione francese, fosse in una qualche misura collegato a taluni filoni dell’illuminismo europeo in tema di libertà di cui culto.
Naturalmente, finita l’esperienza della Repubblica romana la situazione degli ebrei torna ad essere quella di un comunità emarginata. De Felice si era da sempre interessato al tema dell’antisemitismo e allo sterminio degli ebrei. La sua ricerca continua sulla storia degli ebrei sotto il fascismo, tema approfondito anche con riferimento agli scritti di Piero Calamandrei, Gaetano Salvemini. Studio apprezzato, come dimostra la citazione di Cantimori che concludeva sostenendo che la lezione del libro di De Felice era “aspra e amara” ma gli riconosceva “dal punto di vista storiografico“ di trovarsi di fronte a uno dei migliori libri di storia del fascismo fino ad allora pubblicati. Giudizio di per sé assai lusinghiero, sottolinea Francesco Perfetti. E ricorda come sia stata una sollecitazione di Cantimori sul piano intellettuale a spingere De Felice a studiare la figura e l’attività politica di Benito Mussolini. Quando De Felice cominciò a scriverne la biografia si trovò non solo di fronte al problema del rapporto intercorrente tra Mussolini e il fascismo, ma anche di fronte al più generale problema storiografico di una interpretazione complessiva del fenomeno fascista.
Perfetti sottolinea come, fino all’inizio degli anni ’60, non fosse stato ancora tentato un panorama completo o comunque organico e sistematico delle interpretazioni del fascismo. Unica eccezione essendo stata l’antologia di Costanzo Casucci, del 1961, destinata per molto tempo a rimanere la sola sull’argomento e ad essere, a distanza di poco più di un ventennio della prima pubblicazione di ricordi, proposta in versione talmente ampliata e rivista da presentarsi come un qualcosa di completamente nuovo. In un certo senso il volume sul fascismo e i partiti politici costituì per De Felice un primo tentativo di risposta all’antologia di Casucci ovvero – precisa l’A. – , se si preferisce un tentativo di integrazione della stessa, dal momento che pur con talune riserve “egli considerava giustamente quel lavoro un passo pionieristico ma importante degli studi sul fascismo. Se l’antologia di Casucci affiancava testi coevi al fascismo e analisi critiche posteriori con il risultato che l’attenzione del curatore (ma di fatto anche del lettore) finiva per essere polarizzata più sulle seconde che non sui primi, il volume curato da De Felice rispondeva a una logica diversa. E ciò per il fatto, in verità più formale che sostanziale, che non si trattava di un’antologia vera e propria ma piuttosto della riesumazione di saggi pubblicati tutti in una collanina diretta da Rodolfo Mondolfo e di articoli apparsi, nel contesto di una inchiesta giornalistica, sul quotidiano “Il Resto del Carlino”: si trattava, insomma, di testi o, meglio ancora di “testimonianze” che avrebbe ben potuto completare l’antologia di Casucci”.
È nel 1970 che De Felice dà alle stampe una grande antologia dal titolo “Il fascismo: le interpretazioni dei contemporanei e degli storici”, a giudizio di Perfetti “una più complessa “risposta” o, se si preferisce, una “integrazione” alla pur meritoria antologia di Casucci, ed era, in ogni caso, frutto (e dimostrazione al tempo stesso) dell’enorme lavoro preparatorio cui lo studioso stava attendendo per la stesura della vita di Mussolini non limitandosi cioè, a documentarsi in maniera minuziosa sui fatti pubblici e privati, sulla dimensione biografica cioè, del soggetto del suo lavoro, ma cercando di conoscere e approfondire anche la creazione politica dello stesso Mussolini, cioè il fascismo stesso”. Il volume si segnala per sottolineare come non fosse soltanto opportuno ma necessario ricorrere alle fonti di parte fascista per poter comprendere davvero quello che è il fascismo, come movimento e come regime. A conferma dell’abitudine ad un approccio di tipo filologico e archivistico propria della formazione di De Felice. Le pagine che seguono sono ricche di riferimenti ad annotazioni e commenti dell’opera.
Il capitolo quinto è dedicato “Biografo di Mussolini e storico del fascismo” è una preziosa ricostruzione dell’impegno in quest’opera pure controversa per le polemiche che ha suscitato, in particolare nel volume “Mussolini il rivoluzionario”, proprio con riferimento a questo aggettivo. Di queste polemiche il libro dà conto analizzando le fasi della presa del potere da parte del fascismo. Particolarmente interessante il riferimento all’elaborazione della legge elettorale maggioritaria legata al nome di Giacomo Acerbo che, osserva Perfetti, era nata con l’obiettivo immediato di una stabilizzazione del potere ma che rispondeva anche ad una logica trasformistica tipica del giolittismo. Segue il tomo successivo, “Mussolini il fascista”, dedicato all’organizzazione dello Stato fascista che affronta il trapasso del vecchio stato liberale al nuovo regime, un passaggio che si realizzò “in maniera graduale dal momento che, giungendo al potere sulla base del “compromesso” dell’ottobre 1922 con la vecchia classe dirigente liberale e con i cosiddetti “fiancheggiatori”, il fascismo riuscì, sì, a conquistare il governo ma non completamente lo Stato”. Nel rispetto dello Statuto che costituiva una linea di demarcazione al di là della quale i fiancheggiatori non sarebbero stati più disposti a concessioni. Questi, dopo la svolta politica del 3 gennaio 1925, sarebbero stati “fascistizzati”, riuscendo “a derivoluzionare il fascismo, renderlo in buona parte un loro strumento e a farlo rientrare in larga misura nell’alveo della tradizione conservatrice”.
Perfetti richiama anche l’attenzione che De Felice aveva riservato ai rapporti tra D’Annunzio e Mussolini, con riguardo anche ai rapporti di filiazione diretta tra fiumanesimo e fascismo. Due protagonisti indubbiamente diversi, come dimostra anche la pubblicazione del carteggio tra D’Annunzio e Mussolini, un evento storiografico importante.
Perfetti segue il lavoro di De Felice, il volume il tomo dedicato agli anni del consenso. Materia che il volume tratta con riferimento alle varie interpretazioni, anche in area fascista, come quella di Dino Grandi che degli eventi dii quegli anni sarà un protagonista, compresa la svolta del 25 luglio 1943.
Il testo dà conto del dibattito seguito alla pubblicazione dei volumi di De Felice, alle interpretazioni di Romeo e di Valiani, a quella che Perfetti definisce una vera e propria offensiva contro De Felice che “si scatenò dopo la pubblicazione della “Intervista sul fascismo”. Un testo, questo, molto importante, “per il discorso sulla individuazione del cosiddetto “fenomeno fascista”, ma che aveva la caratteristica di aver tradotto in termini semplici e facilmente assimilabili le tesi… più dirompenti del volume, tesi che mettevano in crisi pressoché tutti i discorsi storiografici correnti o si contrapponevano ad essi con ben solide argomentazioni”.
Di grande interesse anche i riferimenti alla caduta del fascismo, quindi alla riunione del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, alla sua preparazione e alle iniziative assunte in proposito dai gerarchi fascisti il relazione all’iniziativa di Dino Grandi ed a quelle assunte dal re Vittorio Emanuele III che comunque appariva intenzionato in ogni caso a destituire Mussolini. Poi la guerra civile, la nascita della Repubblica Sociale Italiana sono ancora un prezioso contributo di De Felice alla conoscenza di avvenimenti cruciali della storia nazionale. Quindi il dopoguerra sul quale Perfetti si sofferma, giungendo a considerare gli eventi più recenti, il rapimento Moro, il governo Craxi e l’attenzione prestata ai temi della nazione dello Stato e della democrazia.
Al termine della lettura di questo volume ricco di spunti di riflessione, guidato dalla mano ferma di Francesco Perfetti quanto all’impegno scientifico ed all’opera di De Felice e di quanti con lui si sono confrontati sui temi della ricerca storica sono consapevole che un lettore attento avrà da rimproverarmi di aver trascurato più di qualche annotazione interessante dell’Autore su questo o quel profilo. Un invito a leggere e rileggere questo monumentale viaggio con De Felice tra i fatti di un periodo della storia nazionale ancora di attualità nel dibattito della politica che non può fare a meno di riferimenti ad un passato che allunga le sue ombre sul presente, tra chi lo guarda con malcelata nostalgia e chi ne giudica severamente l’esperienza, a fronte della tradizione risorgimentale e statutaria nell’ambito della quale il fascismo è stato, crocianamente, una parentesi, che la poderosa documentazione raccolta e annotata con rara capacità dal grande studioso del quale Perfetti sottolinea il “realismo storico” ci consente di studiare.